




Eccoci al terzo concerto, siamo nella bellissima Villa Fondi, anzi villa Fondi de Sangro, dal nome del primo proprietario, che ne ordina la costruzione nel 1840. Distrutta quasi completamente dal terremoto del 1980, viene successivamente acquistata dal comune di Piano di Sorrento, che la apre al pubblico, rendendo possibili numerose manifestazioni, come il concerto di stasera, e aggiungendovi al suo interno il museo archeologico territoriale della Penisola Sorrentina.
Se con Cordis Corde abbiamo assistito al trionfo della chitarra e del mandolino, con Tactus torniamo al pianoforte.
Come per Gentle Sax e Cordis Corde, non è affatto scontato ricordare l’unicum che si era percepito nella presentazione dell’11 aprile, un vero e proprio fare squadra, che anche stasera trova pieno riscontro, in ogni parola che viene pronunciata negli interventi introduttivi da chi ha permesso l’armonioso svolgimento della rassegna, che non sarebbe stata possibile senza il supporto anche di una sola persona che ha parlato stasera come negli altri due appuntamenti, a partire dal Vicesindaco Dr.Gianni Iaccarino, che introduce il concerto. Senza di lui questa serata non sarebbe stata possibile, dato che ha autorizzato che Tactus venisse rappresentato proprio qui; un immenso grazie alla D.ssa Silvana Natale; alla Preside dell’Istituto raro ad indirizzo musicale Francesco Grandi, Prof.ssa Pasqua Cappiello; alla Direttrice Artistica della rassegna Grandi in Concerto, la Ma Emma Innacoli, che ha organizzato in maniera magnifica questa serata, con una meravigliosa scelta dei brani di musica classica che compongono Tactus. Nell’intervento conclusivo, la Ma Innacoli presenta le star di questa serata: Claudio Caccioppoli, ex allievo del liceo Grandi, con gli studenti Claudia e Francesco Ercolano, Davide Esposito, Matteo Liguori, Roberta Palomba, Giuseppe Somma e Antonino Starace, con i docenti di Pianoforte M° Riccardo Caruso e la Ma Annalisa Pepe, coordinatrice del gruppo docenti del Liceo musicale.
Si parte con Sonata III in La maj dalle 31 sonate per forte-piano di Domenico Cimarosa (1749, Aversa – 1801, Venezia).
Abile violinista, clavicembalista e organista, Cimarosa è un esponente di spicco del Classicismo ed è considerato uno dei maggiori musicisti italiani della seconda metà del XVIII secolo e uno dei grandi rappresentanti della scuola musicale napoletana. Figura centrale dell’opera italiana, ha dato un notevole sviluppo all’opera buffa. Musicista fecondo, ha scritto numerose composizioni tra oratori, messe, musica vocale e strumentale e soprattutto 99 opere liriche di cui la più celebre è Il matrimonio segreto del 1792.
Tra i principali lavori strumentali rientrano le 88 sonate per fortepiano, attualmente note come sonate a un solo movimento ma in realtà concepite come sonate a due o tre movimenti.
Di queste 88 sonate inizialmente ne erano conosciute solo 32, tra cui la sonata qui rappresentata. Negli anni ’70 del XX secolo, dopo un lungo periodo di oblio, viene iniziato un esaustivo lavoro di approfondimento delle sonate di Cimarosa, e nel 2016 il pianista Dario Candela porterà a termine l’incisione integrale delle 88 sonate di Domenico Cimarosa per Dynamic, ricevendo il premio internazionale dedicato al compositore nel 2018.
Il brano successivo è Allemande, dalla Suite francese n.4 in Mi b maj n.815 di J.S.Bach (1685-1750), quarta di sei suite francesi.
Considerato uno dei più grandi compositori nella storia della musica, le opere di Bach sono notevoli per profondità intellettuale, padronanza dei mezzi tecnici ed espressivi e per bellezza artistica. La sua fama è dovuta all’ampio e magistrale utilizzo del contrappunto, all’organizzazione armonica e tematica delle sue opere e all’inclusione di temi e motivi sacri – specialmente dalla musica sacra del culto luterano – e profani, oltre che alla capacità di padroneggiare i diversi stili nazionali – principalmente lo stile tedesco, quello italiano e quello francese, che approfondisce. È considerato uno dei massimi maestri di forme musicali come il canone, la cantata e la fuga.
Le Suites francesi BWV 812-817 sono una raccolta di sei composizioni per clavicembalo solo. Sebbene le suite da 1 a 4 siano in genere datate al 1722, è possibile che la numero 1 sia stata scritta precedentemente.
Composte fra il 1722 e il 1725, vengono soprannominate francesi solo nel 1762 dal critico musicale F.Wilhelm Marpurg, in contrapposizione con le Suites inglesi, sempre di Bach; tale accezione viene resa comune nel 1802 da un musicologo nonché organista tedesco, J.N.Forkel, che dichiara: «Vengono generalmente chiamate Suite francesi perché sono state scritte secondo il gusto francese». In realtà questa asserzione risulta inesatta, in quanto le suite seguono abbondantemente sia i canoni compositivi francesi sia quelli italiani.
Il manoscritto originale purtroppo è andato perso, e l’ornamentazione varia a seconda delle fonti: ad esempio, in alcuni manoscritti vengono allegate altre due Suite a quelle francesi convenzionali, la BWV 818 in LAm e la BWV 819, in MIb maj.
La Allemande qui eseguita è il primo degli otto movimenti che compongono questa suite: 1)Allemanda, 2)Corrente; 3) Sarabanda; 4) Gavotta I; 5) Gavotta-BWV 815a; 6) Aria; 7) Minuetto; 8) Giga.
Segue un estratto di Valzer in mi maj op.39 del 1878 di P.I. Čajkovskij (1840-1893), tratto dall’op.39 Album pour enfants, 24 pezzi per pianoforte.
Čajkovskij è stato un compositore russo del periodo tardo-romantico, le cui composizioni sono tra le più note del repertorio classico. Ha unito nel suo stile caratteristiche della musica tradizionale russa alla prassi musicale classica.
Le sue opere spaziano attraverso tutti i generi, includendo sinfonie, balletti, musica sinfonica, musica da camera, musica sacra e 80 opere, fra questa qui rappresentata.
Tra le composizioni più popolari i tre balletti Il lago dei cigni, La bella addormentata e Lo schiaccianoci, le ultime tre sinfonie, il Concerto per pianoforte e orchestra n.1, il Concerto per violino e orchestra e l’Ouverture 1812.
Culturalmente distante dai compositori russi a lui contemporanei d’ispirazione nazionalista passati alla storia come il Gruppo dei Cinque – fra i cui componenti si annovera Musorgski, l’autore di Quadri di un’esposizione, Čajkovskij rivela nella sua musica uno spirito cosmopolita, studiando tutta la vita la musica dell’Europa occidentale.
Dopo Čajkovskij…segue la seconda parte.
Autore: Luca Isaja
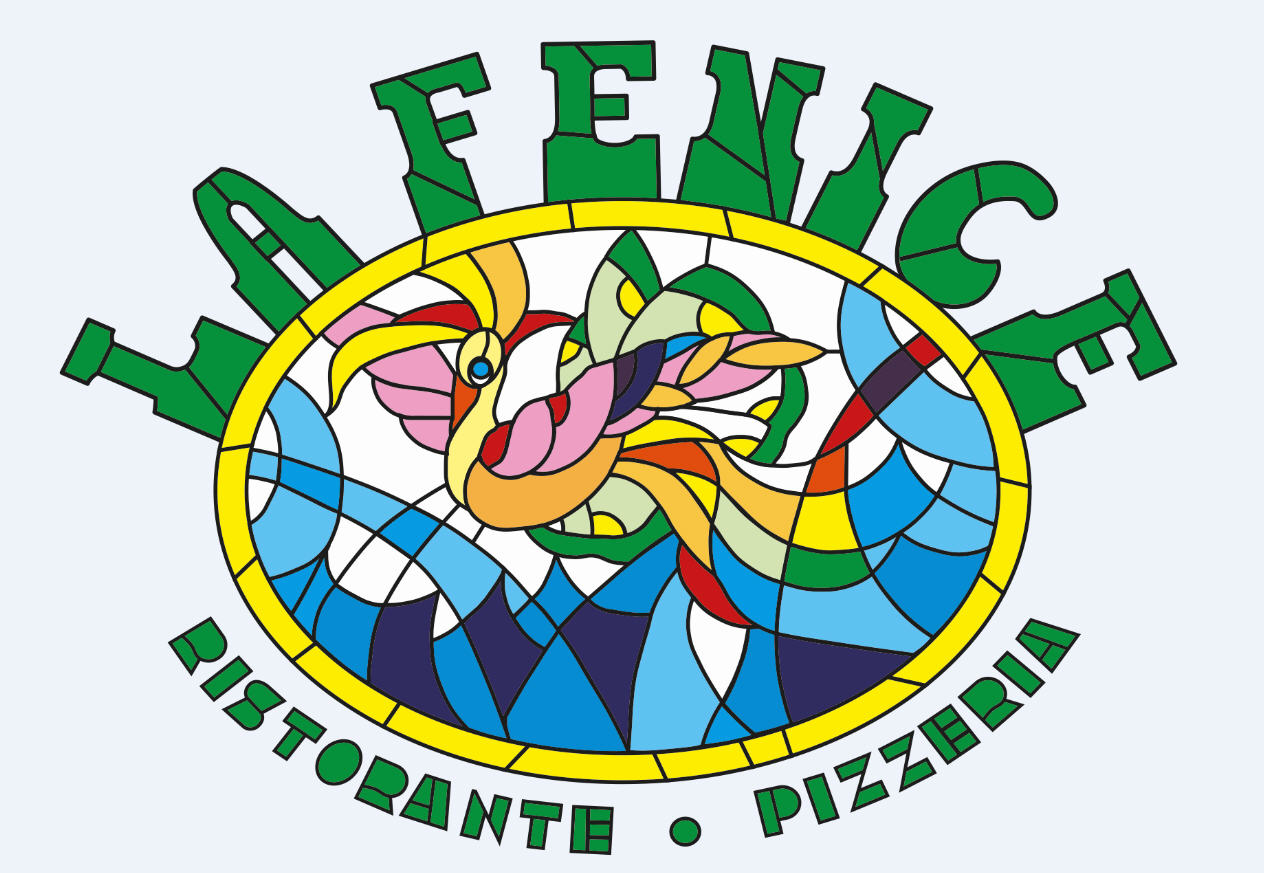 Ristorante La Fenice
Ristorante La Fenice 