





Eccoci alla quinta tappa della rassegna Grandi in Concerto, rappresentato per la seconda volta nella meravigliosa Villa Fondi de Sangro a Piano di Sorrento, dove si rappresenta il concerto Voci in Villa, al posto di Voci in chiostro a Sorrento, rimandato di un giorno per motivi tecnico-organizzativi.
Stasera ringraziamo vivamente il Comune di Piano di Sorrento, nelle persone del Dr.Gianni Iaccarino, vicesindaco e Assessore alla Cultura; della D.ssa Pinella Esposito, consigliera comunale con delega alle Politiche Sociali; della D.ssa Antonella Arnese, assessore alla Gentilezza, oltre che del Sindaco Dr.Salvatore Coppola.
Vivissimi ringraziamenti anche al parroco della Basilica di San Michele Arcangelo, don Tonino.
Un sentitissimo grazie alla Prof.ssa Pasqua Cappiello, alla Ma Emma Innacoli, alla D.ssa Silvana Natale e ai docenti, la Prof.ssa Daniela Innamorati, la Prof.ssa Maria Ercolano, la Prof.ssa Annalisa Pepe e il Prof.Antonino de Rosa.
Un infinito grazie va altresì agli alunni-artisti che si esibiscono questa sera, i talentuosi alunni Emanuela Caccioppoli, Natalia Colonna, Massimiliano Ercolano, Luana Esposito, Miriam Fruscio, Aurora Lazzari, Mariarosa Montefusco, Anna Persico, Brenda Ruggiero, Laura Russo, Simone Schettino, Anna Scorziello, Silvia Sparano, Fernanda Terminiello e Federica Vanacore.
Il concerto si apre con un brano tratto dalla raccolta Storia della canzone napoletana di Aurelio Fierro e Vincenzo de Meglio, libro edito da Luca Torre del 1994 contenente 150 spartiti.
Questo brano di apertura, Cannetella, cantato da tutti i partecipanti, è un brano inserito nell’opera Lo cunto de li cunti del poeta napoletano Giovambattista Basile.
Conosciuta anche come Pentamerone – Cinque giornate, Lo cunto de li cunti – Il racconto dei racconti in italiano – è una raccolta di 50 racconti, sul modello del Decamerone di Boccaccio, pubblicata postuma tra il 1634 e il 1636.
Il racconto di cornice infatti si svolge in cinque giornate, in cui dieci donne si raccolgono alla corte di un principe per saziare la voglia di storie della sua sposa.
Cannetella, primo racconto della terza giornata, ha appunto come protagonista la principessa Cannetella, figlia del re di Belpoggio, la quale dichiara di non voler prendere marito, per cui trova continuamente veri o presunti difetti in ogni possibile pretendente fino a che non incontrerà l’abile mago Fioravante, nemico del re. Dopo essere riuscito ad avere la mano di Cannetella, Fioravante finirà ucciso per mano degli abitanti di Belpoggio, i quali libereranno la principessa dalle sue grinfie dopo svariate vicissitudini.
Il Pentamerone riscuote grande successo in Europa, tanto da offrire materiale di confronto e ispirazione per Perrault e i fratelli Grimm: il Pentamerone infatti presenta alcune delle prime versioni scritte di fiabe quali Il gatto con gli stivali – Cagliuso, Cenerentola – La gatta Cenerentola , La bella addormentata nel bosco – Sole, Luna e Tania, Raperonzolo – Petrosinella, e molte altre. A dispetto dell’enorme successo in Europa, non può dirsi altrettanto in Italia, dove all’inizio riceve l’attenzione solo da parte dei letterati interessati alla letteratura dialettale, dopo di che il Pentamerone viene dimenticato per molto tempo e le fiabe giudicate immorali e di cattivo gusto, tutto questo fino al 1925, anno in cui il filosofo Benedetto Croce curerà la prima traduzione in italiano.
Il brano successivo è Fox della luna, tratto dall’opera Il paese dei campanelli, operetta in tre atti su libretto di Carlo Lombardo, musiche di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato.
Il paese dei campanelli ha come trama un ruotare intorno a una vicenda di incroci multipli di coppie, trattata con leggerezza e bonaria ironia e ambientata in un paesino dell’Olanda in cui su ogni tetto sono posti dei campanelli: secondo una leggenda, essi sarebbero le “guardie” del focolare domestico e inizierebbero a suonare nel momento in cui una donna si appresti a tradire il marito. Fox della luna, tratta dal secondo atto, pare sia stato scritta dallo stesso Lombardo, convinto che nella partitura pur pregevole di Ranzato mancasse uno di quei brani memorabili che la gente canticchia già all’uscita del teatro.
Il paese dei campanelli, rappresentata per la prima volta nel 1923 a Milano, riscuote da subito un notevole successo, e insieme a Cin-ci-là è l’opera che non è mai uscita dal loro repertorio.
Dal Paese dei campanelli passiamo a Venite inginocchiatevi da Le nozze di Figaro di W.A.Mozart, opera in quattro atti.
Le nozze di Figaro è la prima delle tre opere buffe in italiano da lui composte su libretto di Lorenzo da Ponte, che per Mozart aveva scritto anche Don Giovanni e Così fan tutte.
Il libretto, musicato da Mozart a ventinove anni, è tratto dalla commedia La folle giornata o Il Matrimonio di Figaro di Beumarchais – autore della trilogia di Figaro: Il barbiere di Siviglia, Il matrimonio di Figaro e La madre colpevole.
L’opera debutta al Burgtheater di Vienna il 1º maggio 1786 e per la prima volta in Italia due anni più tardi, precisamente a Firenze.
L’aria Venite, inginocchiatevi è il dodicesimo di ventotto brani, inserito nel secondo atto.
La rappresentazione successiva è l’aria O mio babbino caro, tratto dall’opera Gianni Schicchi, di Giacomo Puccini, opera comica in un atto, su libretto di Giovacchino Forzano.
Gianni Schicchi, basata su un episodio del Canto XXX dell’Inferno di Dante Alighieri, vv. 22-48, è la terza opera del Trittico – Trittico è il titolo cumulativo con cui sono conosciute le tre opere in un atto di Puccini: Il tabarro su libretto di Giuseppe Adami, Suor Angelica e appunto Gianni Schicchi.
O mio babbino caro, cantata da Lauretta – la figlia di Gianni Schicchi – è caratterizzata da una grande intensità lirica; nella melodia l’autore riprende quella esposta inizialmente nello stornello di Rinuccio Donati – appartenente alla ricca famiglia fiorentina Donati e follemente innamorato di Lauretta – Firenze è come un albero fiorito, fra la prima e la seconda strofa.
Gianni Schicchi, disprezzato dalla famiglia Donati in quanto ritenuto uomo della gente nova, ha uno scontro molto aspro con tutti i suoi componenti, al punto da mettere a rischio la storia d’amore tra Rinuccio e Lauretta, che implora il padre di aiutarla per riuscire finalmente a realizzare il suo sogno.
E l’occasione arriva, è il 3 giugno 1219: Schicchi, famoso in tutta Firenze per il suo spirito acuto e perspicace, viene consultato proprio dai Donati in quanto il loro parente Buoso, ricco mercante appena deceduto, ha disposto che tutti i suoi beni vadano a un vicino convento di frati, lasciando tutti i parenti a bocca asciutta, per cui chiedono a Schicchi di escogitare un sistema che possa aggirare questa situazione estremamente incresciosa.
Inizialmente Schicchi rifiuta di aiutarli, ma le preghiere della figlia Lauretta lo spingono a tornare sui suoi passi e a escogitare un piano, che si tramuterà successivamente in beffa. Tale piano porterà lo stesso Schicchi a divenire proprietario della casa di Buoso, nonché di tutti i suoi beni, con notevole ira dei parenti.
E’ così esaudita l’accorata preghiera di Lauretta, che a questo punto abbraccia teneramente Rinuccio, mentre Gianni Schicchi, compiaciuto della sua astuzia, contempla la loro felicità.
O mio babbino caro viene rappresentata per la prima volta al Metropolitan di New York il 3 novembre 1918, con notevole successo.
Il brano successivo, Lascia ch’io pianga di Georg Friedrich Handel è una celebre aria per soprano tratta da Rinaldo, opera in tre atti su libretto di Giacomo Rossi.
Rappresentata per la prima volta al Queen’s Theatre di Londra il 24 febbraio 1711, è la prima opera su libretto italiano specificamente composta per la capitale inglese e costitusce la base per il successivo quarantennale successo di Händel in Gran Bretagna.
Al termine di questa aria abbiamo il brano Somewhere tratta dal musical West Side Story di Leonard Bernstein, che abbiamo già ascoltato nel medley finale del primo concerto Gentle Sax.
A questo punto, ascoltiamo il brano La Barcarolle, tratto da I racconti di Hoffmann del compositore e violoncellista tedesco Jacques Offenbach (Colonia, 1819 – Parigi, 1880).
La Barcarolle, considerata uno dei capolavori assoluti della musica classica, è presente all’inizio del terzo atto de I Racconti di Hoffmann, opera in 4 atti.
In realtà non viene realizzata per I Racconti di Hoffmann, ma si tratta di una partitura scritta da Offenbach nel 1864 e pensata come Canzone degli Elfi nel Die Rheinnixen – Le fate del Reno.
Segue seconda parte.
Autore: Luca Isaja
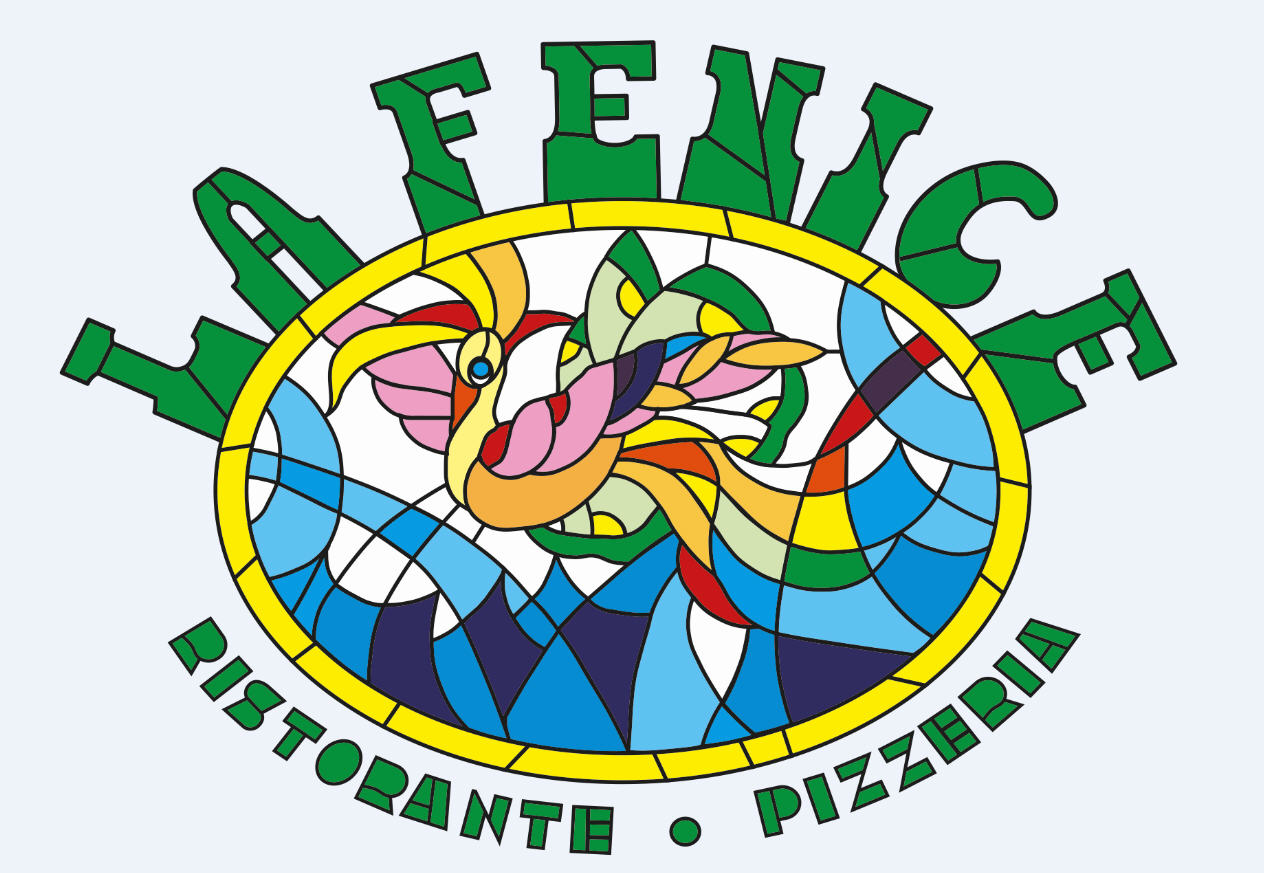 Ristorante La Fenice
Ristorante La Fenice 