



Il concerto si articola con brani che, già belli di per sé, esaltano ulteriormente le qualità dei talentuosi allievi sopracitati, i quali valorizzano vicendevolmente dei brani meravigliosi scelti con sapiente cura. Si inizia con Ave Maria del compositore argentino Astor Piazzolla, da genitori italiani, chiamato Astor per via del violinista Astor Bolognini, amico e cliente del padre; strumentista d’avanguardia, fatto che gli costerà non poche critiche da parte dei puristi del tango per via del Nuevo Tango, nato dalle sue commistioni fra tango e jazz, è considerato tra i musicisti più importanti del 20° secolo, vantando oltretutto numerose collaborazioni con artisti italiani, tra cui Gerry Mulligan, Tullio De Piscopo, Mina, Milva e numerosi altri; Ave Maria è un brano di profonda religiosità, scritto per oboe e pianoforte nel 1984 con il titolo Tanti anni prima per il film Enrico IV di Marco Bellocchio, dall’omonima commedia di Luigi Pirandello. in cui era il tema di Matilde, impersonata da Claudia Cardinale che vi lavorava insieme a Marcello Mastroianni. Poco prima di morire, con la raccomandazione di eseguirla al momento giusto, Piazzolla dona questa Ave Maria alla cantante Milva, sua amica dal 1981, che l’ha proposta al pubblico mondiale nell’ambito del Grande Giubileo del 2000.
Il secondo brano è Celine Mandarine, composta da Alain Crepin, in occasione della prima audizione pubblica della figlia Celine, da cui il titolo.
Il brano è composto di tre parti, come a simboleggiare una giornata. La prima parte ha un andamento dolce; la seconda è caratterizzata da un andamento molto vivace, per poi tornare a un andamento soave, che segna la terza e ultima parte.
Il brano successivo, Andante ma non troppo, è composto dal francese Eugène Bozza. Valentissimo violinista, come il papà, Bozza è un musicista prolifico, compone circa 250 opere, la maggior parte per fiati, nonostante sia violinista. La sua attività inizia negli anni ’20 come primo violino dell’Orchestra Pasdeloup, per poi assumere per oltre dieci anni l’incarico di direttore dell’Opera – Comique fino al 1948, e dal 1950 fino al 1975 dirige la Scuola di Musica di Valenciennes; al termine di questo incarico si dedica esclusivamente alla composizione fino alla sua morte, avvenuta nel 1991.
Giungiamo così alla terza esecuzione, Andante allegro. Viene composta nel 1958 dall’organista e compositore francese André Chailleux. Cominciando con un passaggio lirico prestato, il brano si sposta lentamente verso un 6/8 Allegro, che include molti svolazzi di semicrome per il sassofono.
Si prosegue con Pavane Op.50 in Fa# min di Gabriel Urban Fauré, composta nel 1887. Fauré, considerato il maestro della melodia francese, viene riconosciuto per il suo genio armonico. Le sue opere, di fattura classica, si distinguono tanto per la finezza della loro melodia, quanto per l’equilibrio della loro composizione, e Pavane, una delle sue opere principali, non fa eccezione; Pavane appartiene al primo di tre periodi, conclusosi nel 1890, periodo caratterizzato dall’influenza della musica tedesca e italiana e da un certo classicismo.
Destinataria della dedica è la contessa Elisabeth Greffulhe, di cui la pavana – da padovano -> danza padovana: danza diffusa specialmente nei paesi latini nel 16° e 17° secolo – è intesa essere una sorta di ritratto in musica. Su sua richiesta Fauré aggiunge in un secondo tempo una parte per coro – soprani, alti, tenori e bassi – su parole di Robert de Montesquiou-Fezensac, cugino della contessa.
L’opera è stata reinterpretata da numerosi artisti, tra cui i Jethro Tull in The Jethro Tull Christmas album, da Giusto Pio nell’album Restoration del 1983 con arrangiamenti di Franco Battiato; il tema di Pavane viene tra l’altro campionato dal rapper Xzibit dalla versione vocale di Barbra Streisand.
A Pavane segue Gymnopedie n.1 di Erik Satié.
Non è esagerato parlare di Satié come un bruco che si trasforma in una splendida farfalla, dovrà infatti fare i conti con un’infanzia difficile – a sei anni, nel 1872, muore la madre; oltretutto abbandona svariate volte lo studio del pianoforte, a causa di un’educazione severa impartitagli dalla nuova compagna del padre, una pianista tanto esperta quanto austera. Per lo più, al Conservarorio di Parigi viene bocciato in quanto i suoi insegnanti lo ritengono privo di talento.
Nonostante tutto ciò, il giovane Erik sta sviluppando una personalità molto articolata connotata da molte sfaccettature da vero artista: estremamente intelligente, tuttavia bizzarro, accattivante ma anche parecchio scomodo.
Continuando a studiare per conto proprio, nel 1884 compone la sua prima opera, l’Allegro.
Con varie opere all’attivo, nel 1888 compone le tre Gymnopedie – danza nuda accompagnata da canto. Per la scelta del termine il nostro Erik è probabilmente ispirato dal Dictionnaire de Musiche di Dominique Mondo, oltre che dal poema Les Antiques del suo amico poeta Patrice Dominique de Latour, e nell’estate del 1888 viene pubblicata sulla rivista La musique des familles la prima Gymnopedie. Tutte e tre le opere sono brani autonomi riuniti in un’unica raccolta dal padre, editore di musica nel tempo libero. Le Gymnopedie sono su tempo di valzer lento. La prima in particolare, quella qui eseguita, è caratterizzata da un andamento lento e doloroso, con una successione di due accordi alternati nelle prime battute, Re7maj e Sol7maj. Questa successione influenzerà vari anni dopo il famoso compositore Claude Debussy dal simbolismo all’impressionismo.
E veniamo al brano successivo, Salut d’amour op.12 di Edward William Elgar, musicista inglese.
Molte sue opere sono entrate nel repertorio di concerti di musica classica britannica e internazionale. Salut d’amour rientra nelle sue composizioni più note insieme alle Variazioni Enigma, le Pomp and Circumstance Marches, i concerti per violino e violoncello, insieme a due sinfonie; oltre a tutto ciò ha composto anche opere corali, musica da camera e vaie canzoni.
Elgar è altresì considerato il primo compositore a prendere sul serio il grammofono, dirigendo una serie di registrazioni acustiche delle sue opere.
Tornando a Salut d’amour, Elgar termina il pezzo nel luglio del 1888, quando ha una relazione romantica con Caroline Alice Roberts e lo chiama Liebesgruss (Saluto d’amore) per la fluidità della signorina Roberts nel tedesco. Durante il loro fidanzamento lei gli aveva già presentato una poesia, The Wind at Dawn, che Elgar mise in musica e, quando lui tornò a casa a Londra il 22 settembre da una vacanza a casa dell’amico Dr. Charles Buck a Settle, le dona Salut d’Amour come regalo di fidanzamento.
La dedica è in francese: à Carice. Carice è una combinazione dei nomi di sua moglie Caroline Alice, ed era il nome che avrebbero dato alla figlia nata due anni dopo.
Al termine di Salut d’amour viene eseguito The Old Castle – in Sol#min. 6/8, andante molto cantabile e con dolore – secondo di dieci quadri da Quadri di un’esposizione (da qui in poi QdE) del compositore russo Modest Petrovich Musorgsky (N.1839 M.1881). Grande innovatore della musica russa nel periodo romantico, Musorgsky si sforza di raggiungere un’identità musicale unicamente russa, spesso in deliberata sfida alle convenzioni consolidate della musica occidentale; molte delle sue opere traggono ispirazione dalla storia russa, dal folklore russo e da altri temi nazionali, e QdE è tra queste.
QdE è una suite per pianoforte a soggetto, ed è la composizione per pianoforte più famosa di Musorgskij, ed è diventata, oltre che un pezzo forte del repertorio di molti pianisti, l’oggetto di un gran numero di strumentazioni, specie per orchestra, da parte di altri compositori e musicisti: la versione più nota e più eseguita di queste è senza dubbio quella orchestrata da Maurice Ravel.
Molto interessante la sua genesi: nel 1870 Musorgskij conosce l’artista e architetto V.A.Hartmann, grazie all’influente critico V.Stasov, che li conosce entrambi e segue con interesse le loro attività. I due sviluppano rapidamente un profondo sentimento di amicizia, grazie alla condivisione degli stessi ideali tanto cari a Musorgsky, ma l’amicizia durerà poco: nel 1873, a soli 39 anni, Hartmann muore improvvisamente nel 1873 per un aneurisma, a soli 39 anni.
In suo ricordo, tra febbraio e marzo del 1874, Stasov allestisce una mostra all’Accademia Russa di Belle Arti a San Pietroburgo, dove vengono esposti circa 400 suoi lavori. Musorgskij, che aveva contribuito prestando alcune opere della sua collezione, rimane molto colpito da questa mostra, motivo per cui in pochissimo tempo comporrà Qde, tra il 2 e il 22 giugno 1874.
QdE però vedrà la luce solo nel 1886 grazie al suo amico N.Rimskij – Korsakov, che apporta parecchie modifiche al lavoro originale, convinto che in esso fossero presenti numerosi errori. Solo nel 1930 il compositore Pavel Lam riesumerà il manoscritto originale, pubblicandolo nel 1931.
QdE è composta da quindici brani, dieci ispirati ai quadri e cinque Promenade – passeggiata – che rappresentano il movimento dell’osservatore da una tela all’altra. Le Promenade presentano sempre lo stesso tema, con variazioni più o meno sensibili, quasi a far risaltare i diversi stati d’animo che pervadono il compositore per il quadro appena visto. La ripetizione del tema funge inoltre da elemento di coesione in una composizione altrimenti episodica, basata sui forti contrasti tra un soggetto e l’altro.
La scena di The old Castle si svolge in Francia, dove un trovatore intona la sua struggente canzone d’amore davanti alle mura di un castello medievale, in un paesaggio soffuso di tristezza. È probabilmente l’episodio più lirico dell’intera raccolta, dal tono melanconico e trasognato. L’espressività è sottolineata dai numerosi crescendo e diminuendo; Il canto, in modo minore, è legato e va intonato piano, con espressione, finché piano e forte si fondono formando un unico grande crescendo che porterà alla Promenade successiva.
Dopo questa splendida esecuzione si passa a Vocalise di Sergej Rachmaninoff.
Vocalise, dedicata alla soprano Antonina Nezdanova, è una composizione per voce e pianoforte composta il 19 giugno 1912 come ultima delle sue Quattordici romanze, op. 34. Scritta per voce acuta – soprano o tenore – con accompagnamento di pianoforte, non contiene parole, ma è cantato usando una vocale qualsiasi a scelta del cantante.
Il titolo Vocalise è stato utilizzato dall’autore, perché la sua linea del canto è proprio un esteso vocalizzo da eseguirsi su una vocale a scelta dell’interprete.
La prima di Vocalise ha luogo a Mosca il 25 gennaio 1916, nella versione di Rachmaninoff per voce e orchestra, non per pianoforte. Ciò risulta dalle memorie di Nezdanova.
Gente sax si conclude con un medley di tre brani, Summertime di Gershwin, Somewhere e Tonight di Leonard Berstein, tratti dal musical West Side Story, composto tra il 1953 e 1956 e rappresentato per la prima volta al National Theatre di Washington nel 1957.
Gershwin comincia a comporre Summertime nel dicembre 1933, nell’intento di creare uno spiritual nello stile della musica folk afroamericana del periodo. Il compositore e cantante ucraino-canadese Alexis Kochan ha avanzato l’ipotesi che la melodia possa essere stata ispirata da una ninna nanna di origine ucraina, Oi Khodyt Son Solo Vikon – trad. Un Sogno Passa Davanti alla Finestra, che Gershwin avrebbe ascoltato durante un’esibizione a New York del Coro Nazionale Ucraino Oleksander Koshetz.
Summertime viene inserita nell’opera Porgy and Bess. Nell’opera, la canzone è eseguita prima da Clara nel primo atto come una ninnananna, e poco dopo come contrappunto durante una partita a dadi. Viene ripresa nel secondo atto, sempre da Clara, e infine nel terzo atto da Bess, che la canta per il bambino di Clara.
Seguono ringraziamenti e consegne di fiori. Insomma, Gentle Sax è iniziato nel migliore dei modi ed è terminato a dir poco trionfalmente. Perciò, avanti tutta!
Autore: Luca Isaja
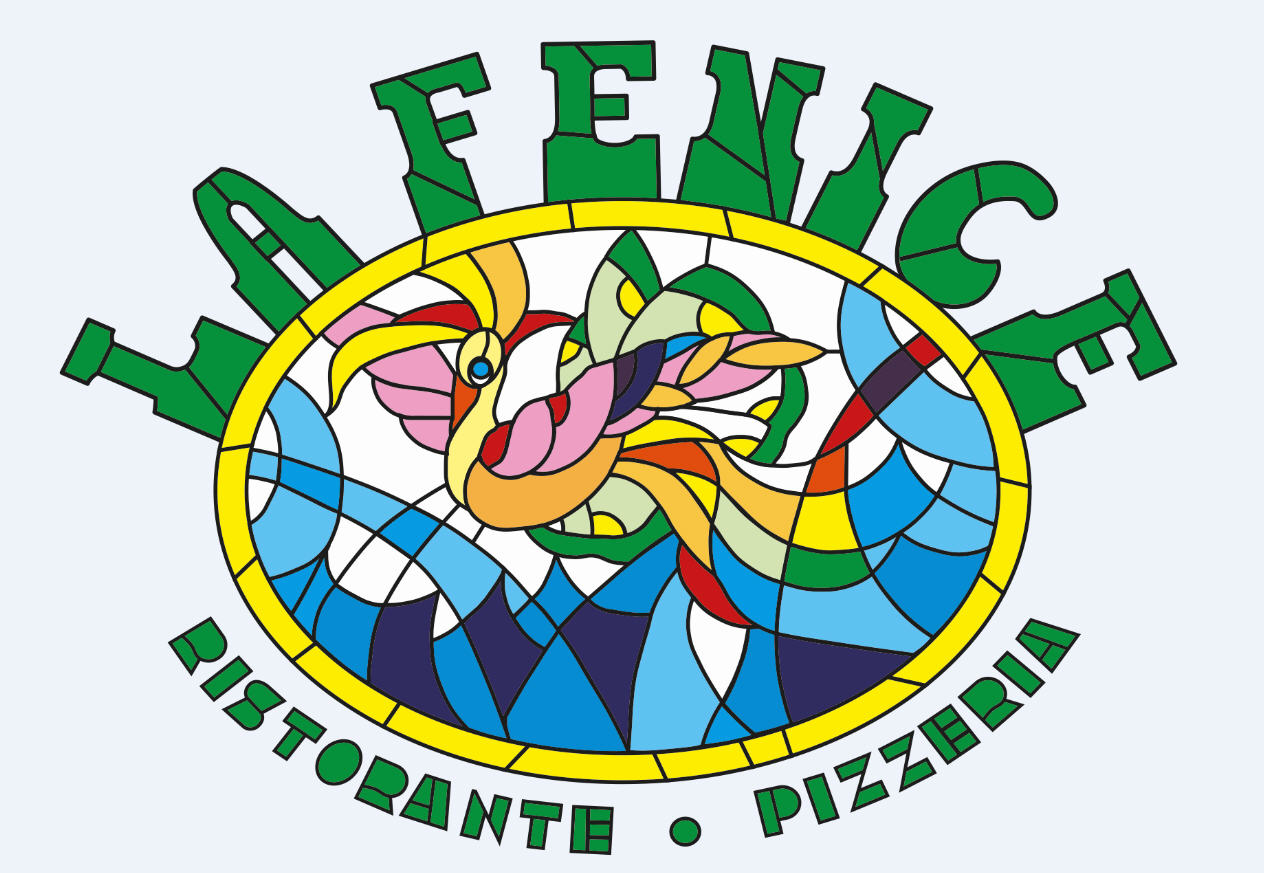 Ristorante La Fenice
Ristorante La Fenice 